Nuove mentalità per nuove varietà
By Giulia Maria Marchetti

Il settore agricolo è uno dei più colpiti dal cambiamento climatico, che ha portato con sé nuove malattie e sfide per gli specialisti del settore. In viticoltura, ad esempio, le temperature crescenti sono responsabili non solo di un forte stress idrico, ma anche della suscettibilità delle colture ai patogeni e stanno inducendo una generale migrazione delle colture ad altitudini sempre maggiori. Questo non è però sempre possibile, in quanto alcune aree geografiche di produzione dei vini non presentano zone montuose sulle quali poter contare per questo spostamento.
L’agricoltura è però allo stesso tempo vittima e carnefice del cambiamento climatico: i fitosanitari sono infatti una fonte di gas serra, poiché derivano da combustibili fossili, e il loro stesso trasporto ed utilizzo è implicato nel surriscaldamento globale. Le temperature crescenti causano un aumento dei patogeni e una diminuzione della resilienza delle colture, che necessitano di quantità sempre maggiore di fitosanitari per poter sopravvivere agli attacchi dei parassiti. Per interrompere questo circolo vizioso non basta però agire sull’agricoltura. Questo settore risponde infatti alle richieste dei consumatori, che si aspettano di acquistare prodotti di elevata qualità ad un basso costo. Non solo: tali prodotti devono essere esteticamente invitanti e la loro produzione deve essere il più naturale possibile. Tutto questo è ovviamente impossibile da ottenere. L’aumento di produttività richiesto dal settore agricolo comporta un aumento dell’uso di fitofarmaci. Questa strategia è in contrasto con l’obbiettivo 2030 dell’Unione Europea, che prevede la riduzione del 50% dell’uso dei pesticidi. Che strada scegliere dunque, davanti a questo bivio?
Il gruppo di ricerca di OenoLab della Libera Università di Bolzano, guidato dal professor Emanuele Boselli, è partito dalla viticoltura per cercare di fornire una risposta a questa domanda attraverso il progetto SUWIR. Questo nasce dalla collaborazione di quattro gruppi di ricerca della Libera Università di Bolzano che hanno unito gli sforzi per studiare il valore dei vini ottenuti in Alto Adige da varietà di uva resistenti alle malattie.
La storia e la filosofia dei vitigni PIWI
I protagonisti dello studio sono i vitigni PIWI (Pilzwiderstandsfähige Reben), ovvero dei vitigni resistenti alle patologie fungine. Questi vitigni nascono alla fine del XIX secolo, quando in Europa dilaga la filossera, un parassita importato dall’America e che stava devastando la viticoltura del continente. La soluzione escogitata fu quella di incrociare le viti europee, appartenenti alla specie Vitis vinifera e che garantivano vini dalle elevate qualità organolettiche, con le viti americane, appartenenti ad altre specie resistenti a diverse patologie. Le politiche lungimiranti dell’Unione Europea volte al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, tra cui il Green Deal, hanno portato alla riscoperta di questi vitigni, caduti nel dimenticatoio.
Le soluzioni offerte dai vitigni PIWI
La coltivazione dei vitigni PIWI si concentra nel Nord Italia ed Europa, dove il clima umido favorisce maggiormente la diffusione dei parassiti, ed è particolarmente popolare nelle zone montane, dove la viticoltura è tendenzialmente a conduzione familiare ed è più difficile reperire manodopera. I vitigni PIWI risultano essere particolarmente promettenti per queste aree: la loro resistenza a diversi patogeni riduce infatti notevolmente la necessità di trattamenti con prodotti fitosanitari. Questa loro caratteristica porta con sé delle implicazioni sociali rilevanti. La riduzione di trattamenti si traduce infatti in un minore intervento dei lavoratori in campo che, a sua volta, comporta una riduzione del rischio di incidenti sul lavoro, un problema rilevante per terreni pendenti come quelli montani.
Inoltre, i vini ottenuti sono ideali per consumatori attenti alla sostenibilità e all’origine delle materie prime poiché nascono da una filosofia incentrata sull’attenzione e sulla valorizzazione del prodotto, grazie all’utilizzo di una quantità notevolmente inferiore sia di pesticidi di sintesi che di rame e zolfo rispetto ai vitigni tradizionali. Questo gioverebbe anche all’ambiente, poiché una diminuzione dell’uso di fitosanitari potrebbe potenzialmente ridurre anche le emissioni di CO2, un aspetto che il progetto SUWIR sta analizzando grazie alla Life Cycle Assessment (LCA), un’analisi che mira a valutare l’impronta ambientale dei processi.
I problemi dei vitigni PIWI
Questi vitigni possono quindi essere una soluzione per numerosi dei problemi presenti in viticoltura. Come mai, allora, non sono ancora così diffusi? “I vini ottenuti da questi vitigni possiedono caratteristiche chimiche e sensoriali peculiari, che li contraddistinguono rispetto ai vini tradizionali. Molto spesso i consumatori cercano di confrontarli con varietà esistenti ma questi vini hanno un’identità propria e vanno valorizzati come tali”, spiega Edoardo Longo, ricercatore del gruppo OenoLab di unibz. Edoardo e colleghi si occupano di analizzare il profilo chimico, aromatico e sensoriale dei vini ottenuti da vitigni PIWI. Durante le loro analisi sono riusciti ad identificare dei marker, ovvero delle molecole chimiche che sembrano essere associate ai fattori di resistenza e potrebbero pertanto permettere di identificare nuove varietà resistenti. Scopo del progetto è anche capire come i consumatori percepiscono questi vini.
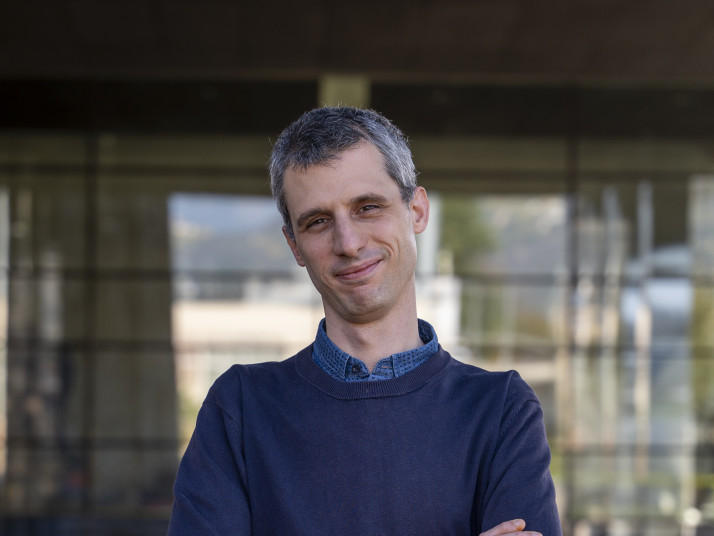
“Un altro problema è la legislazione: in Italia vige un proibizionismo anacronistico. Mentre in Europa i vitigni PIWI possono essere utilizzati per produrre vini DOP, più valorizzati sul mercato in quanto associati a qualità e territorialità, in Italia si fa ancora riferimento al “Testo unico del vino” del 2016, che permette l’uso del vino da vitigni PIWI solo per la produzione di vini IGT, con reputazione e valore di mercato inferiore. Un prodotto, quello ottenuto dai vitigni PIWI, che nasce da una lunga ricerca e che può raggiungere elevata qualità, viene quindi posto in partenza sul mercato con un placement più basso, penalizzando i produttori che scelgono questa filosofia”, avverte Edoardo.
I vini ottenuti da questi vitigni presentano dunque un elevato potenziale, se coniugati ad adeguate pratiche enologiche e alla conoscenza delle loro peculiarità: non sono solo innovativi dal punto di vista chimico e sensoriale, ma hanno anche alle spalle una filosofia fatta di sensibilità e lungimiranza, sia per l’ambiente che per i consumatori. C’è quindi bisogno di un cambio di mentalità e di un’apertura alle novità che il mercato presenta, che porti con sé la valorizzazione della ricerca che sta dietro ai prodotti e dell’attenzione all’ambiente e al territorio che sempre più aziende cercano di promuovere con i loro prodotti. Con l’auspicio che, a questo cambio di mentalità, segua anche un cambio di legislazione.
Il progetto SUWIR nasce dalla collaborazione dei gruppi di ricerca di Enologia, Chimica Agraria, Ingegneria economico- gestionale e Sociologia Economica di unibz.
Related people: Emanuele Boselli, Edoardo Longo